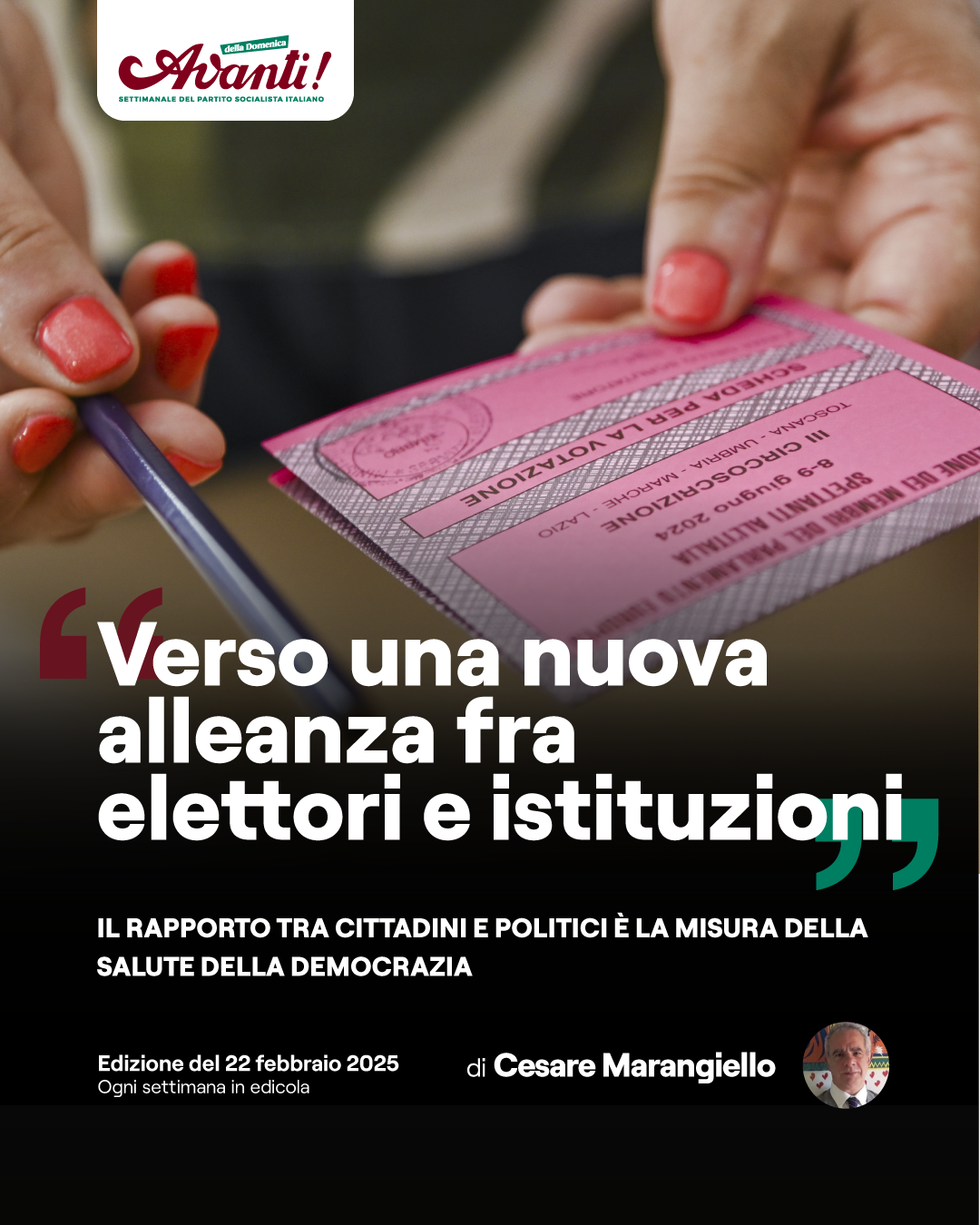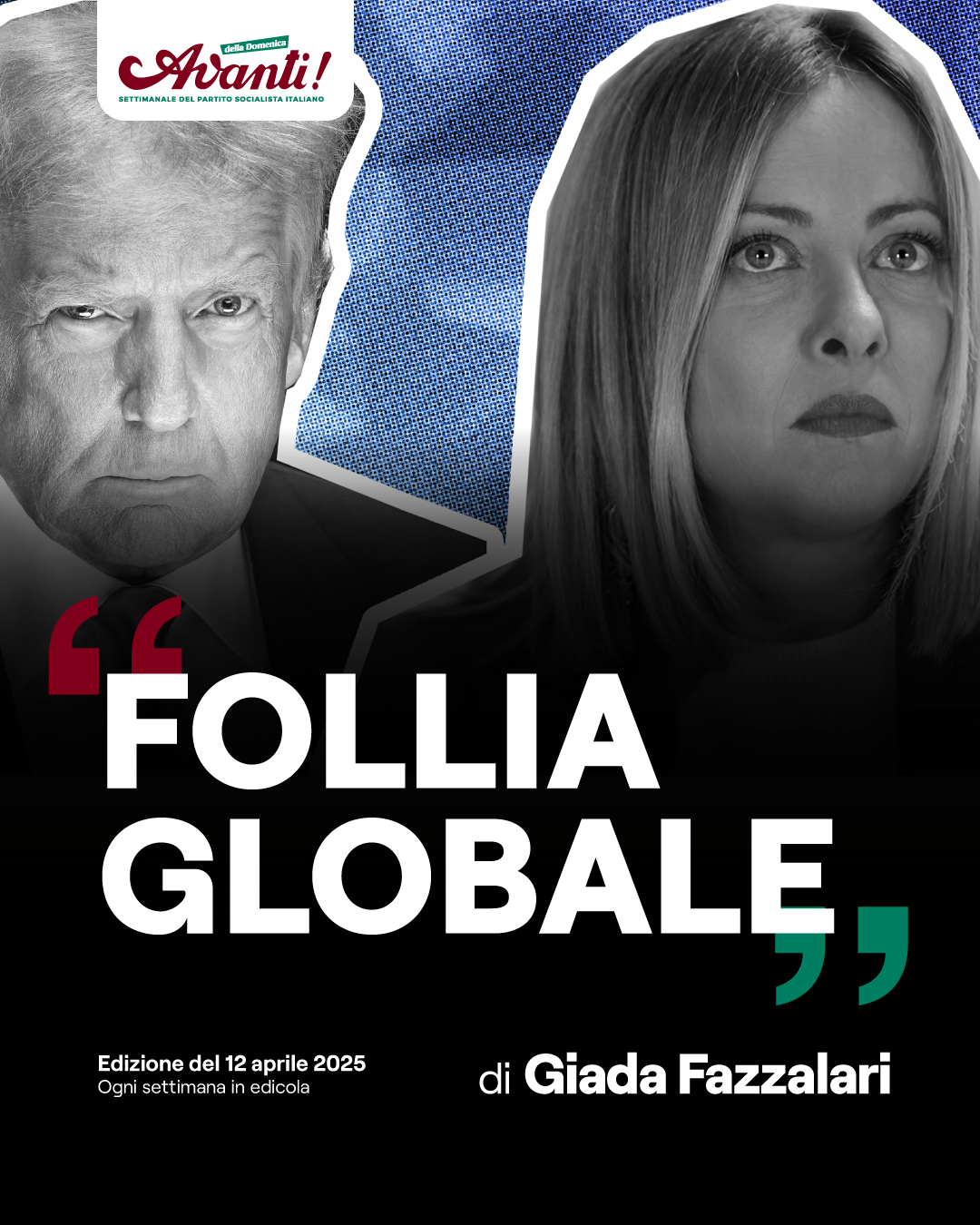di Cesare Marangiello
La relazione tra cittadini e politici è un indicatore chiave della salute democratica di una nazione: ogni Paese la sviluppa in modo diverso, rivelando la propria identità culturale, economica, tecnologica e istituzionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, il rapporto tra elettori e rappresentanti appare più diretto e paritario rispetto alla realtà italiana. Gli aventi diritto al voto partecipano attivamente non solo esprimendo il proprio consenso, ma anche finanziando le campagne elettorali e partecipando ad eventi pubblici come i “Town hall meetings”, incontri in cui i cittadini dialogano direttamente con i loro candidati o rappresentanti politici. Inoltre, sono ampiamente diffusi strumenti innovativi, come il voto anticipato, che permette d’esprimere il proprio consenso prima del giorno stabilito, e il voto per corrispondenza, che consente di inviare la scheda elettorale attraverso il mezzo postale. Queste modalità garantiscono maggiore flessibilità e incentivano la partecipazione, soprattutto per chi ha impegni lavorativi, vive lontano dai seggi o non può recarsi fisicamente alle urne. Negli Stati Uniti, tali misure hanno portato a un tasso di partecipazione elettorale del 66,8% nelle elezioni del 2020, il più alto degli ultimi decenni, sebbene nel 2024 l’affluenza sia risultata leggermente inferiore rispetto alle elezioni precedenti. Tuttavia, questi dati riflettono un coinvolgimento significativo degli elettori, che si percepiscono come parte integrante del processo decisionale. In Italia, al contrario, prevale un rapporto distante e asimmetrico fra cittadini e politici, percepiti come irraggiungibili. Il sistema politico, inoltre, è spesso orientato a breve termine, a scapito delle nuove generazione e con scarsa trasparenza. Secondo il rapporto Eurispes 2024, solo il 33,6% degli italiani ripone fiducia nel Parlamento, un dato fra i più bassi in Europa, mentre la maggioranza (58%) esprime delusione. In più, secondo Transparency International, un’organizzazione internazionale non governativa, fondata a Berlino nel 1993, impegnata nella lotta contro la corruzione, nel 2023 l’Italia si colloca al 42° posto su 180 paesi nell’indice della percezione della corruzione, con un punteggio di 56 su 100. Complessivamente questi dati evidenziano una crisi di fiducia ed un crescente distacco tra cittadini e istituzioni, alimentato dalla percezione di scarsa trasparenza e da una politica focalizzata su obiettivi a breve termine. Uno dei fattori chiave che distingue l’Italia dagli Stati Uniti è l’uso della tecnologia. Negli Stati Uniti, ad esempio, si sperimentano soluzioni di voto digitale impiegando la blockchain, per migliorare trasparenza e sicurezza. In Italia invece, si tende a “conservare più che a innovare”, ignorando il potenziale delle nuove tecnologie nel rafforzare partecipazione e fiducia nei processi democratici. Carl Gustav Jung afferma che “la trasformazione richiede un atto di coraggio e l’abbandono di vecchi schemi”. Questo principio, inizialmente riferito al processo di individuazione dell’individuo, può essere esteso ai cambiamenti sociali e politici, anch’essi frutto dell’azione umana. Se la politica vuole davvero rivolgersi alle persone, deve superare modelli rigidi e pratiche obsolete. Solo attraverso nuove forme di partecipazione, il voto per corrispondenza, il voto anticipato, il voto elettronico o le piattaforme digitali per presentare e votare proposte incentrate sul benessere e sulle reali esigenze dei cittadini, si può ricostruire una solida alleanza democratica e diventare un autentico strumento di progresso sociale. In altre parole, per continuare a ‘far vivere’ e migliorare la democrazia, servono audacia e innovazione: strumenti di partecipazione attiva che possono aiutare a ricreare una collaborazione positiva tra cittadini e istituzioni, basata sull’uguaglianza e sulla condivisione del diritto di voto. È essenziale ricordare che la democrazia non è un sistema statico, ma un “organismo vivente” che richiede costante cura e adattamento. È giunto, perciò, il momento di chiedersi: “Quali cause e soluzioni concrete si possono intraprendere per superare le barriere culturali e istituzionali che ostacolano il progresso e l’innovazione del nostro contesto democratico?”.