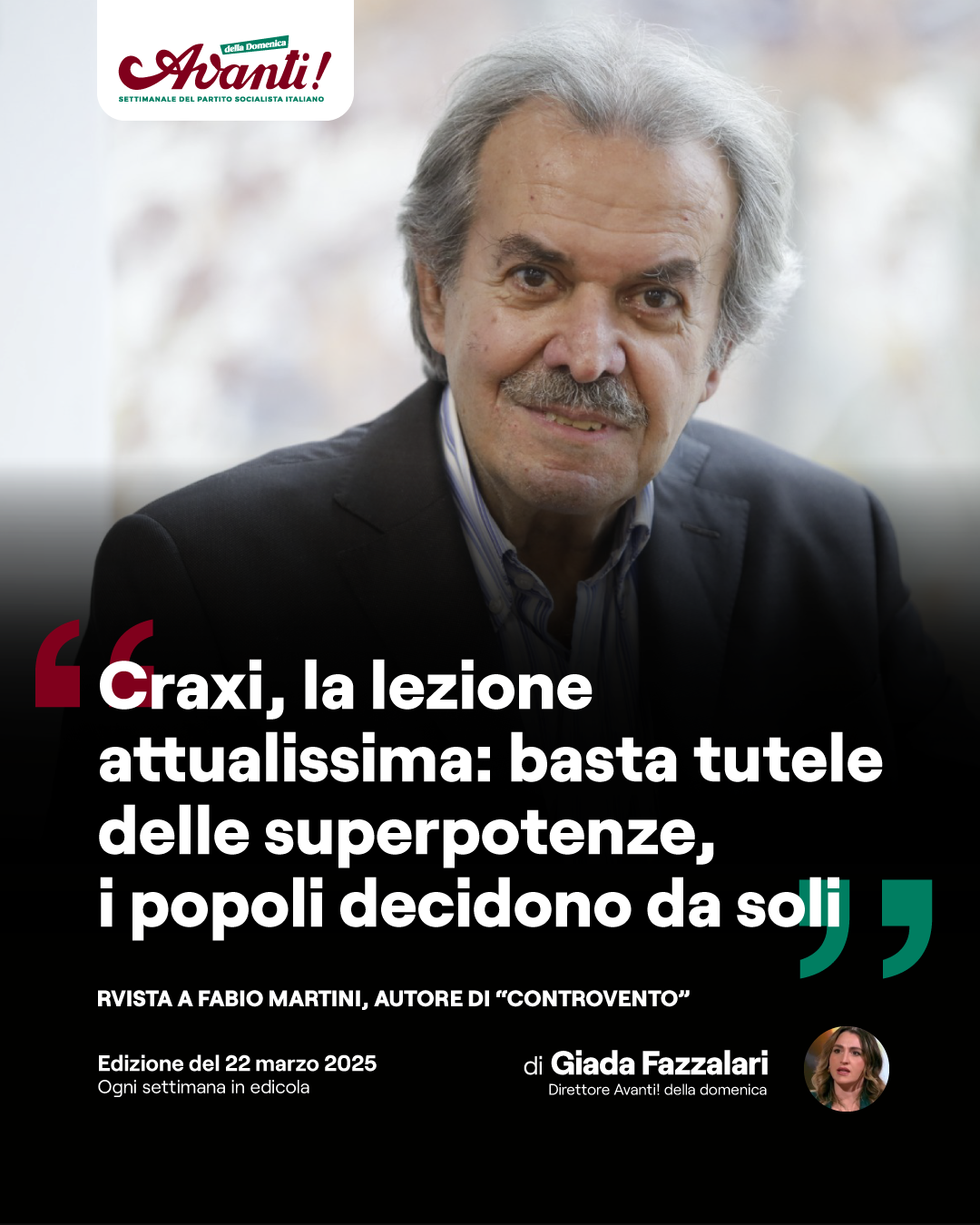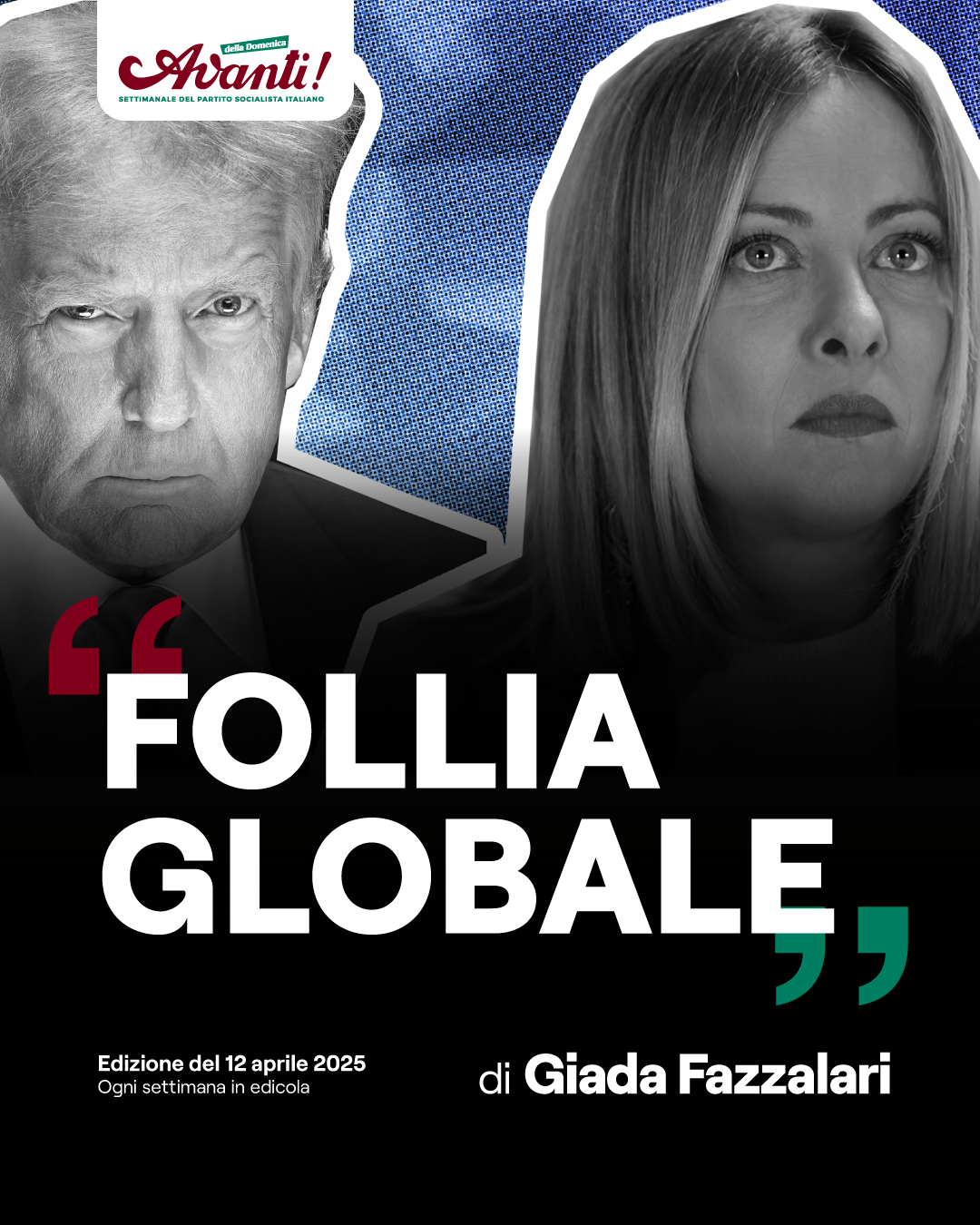di Giada Fazzalari
«Il gran trambusto che sta scuotendo il mondo ci dice qualcosa che sinceramente non avremmo mai immaginato: da quando Bettino Craxi ha lasciato la guida del Psi, 33 anni fa, mai come oggi la sua lezione è diventata così attuale, così comprensibile per tutti, così forte da potersi trasformare in un’arma di lotta per tutta la sinistra». Fabio Martini, dal 1989 giornalista politico e commentatore de “La Stampa”, autore di “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi”, quasi preoccupato dal rischio di apparire retorico, aggiunge subito: «Attenzione: viviamo in una stagione di sensazionalismi e c’è il rischio di essere fraintesi, ma ripercorrendo senza inutili accenti agiografici, la battaglia di Craxi troviamo un filo rosso attualissimo: aiutando i dissidenti dell’Est europeo e i movimenti di liberazione in Sudamerica, favorendo l’installazione degli euromissili contro i missili aggressivi dei sovietici e al tempo stesso facendo accerchiare le teste di cuoio americane a Sigonella, Craxi ebbe sempre la stessa idea: aiutare l’emancipazione degli italiani e degli europei dalle tutele e dai vincoli dei due imperi, americano e sovietico, perché quel che conta è la liberta dei popoli. La loro autodeterminazione».
Partiamo dal partito che Craxi ha guidato per 16 anni, il Psi che celebra il suo congresso: in questo mondo in tumulto che valori possono esprimere i congressi dei partiti?
«In effetti questa è una questione colpevolmente trascurata nella discussione pubblica. Nel 1892, in un bellissimo congresso a Genova, nacque quello che sarebbe diventato – e resta ancora oggi – il più longevo partito italiano: il Psi. Per tutti i partiti italiani nessuno escluso, i congressi sono stati fino al 1992 (per un secolo esatto!), i momenti più solenni per darsi linea politica e classi dirigenti. Da qualche anno, in Italia, i congressi hanno cambiato natura. Voi socialisti siete puntuali, ma quasi tutti gli altri rinviano i congressi all’infinito o li trasformano in eventi auto-celebrativi. E invece i congressi sarebbero – e non solo retoricamente – momenti creativi, di fusione democratica tra base e vertici, tra chi ama la politica e chi la guida. I momenti clou per fare grande la politica».
Oggi la politica in genere segue altri percorsi?
«Prendiamo i partiti più grandi, Fratelli d’Italia, Pd, Lega, Forza Italia e Cinque stelle. La politica è tutta verticistica: leader che ogni giorno danno la linea con la dichiarazione di giornata, di solito con una battuta studiata soltanto per “bucare” lo schermo ma senza un pensiero che duri più di 48 ore. Verticismo perché attorno ai leader ci sono gruppi parlamentari che, grazie alle liste bloccate, sono nominati dall’alto e dunque vantano margini politici ridottissimi. Nessuno ci ha riflettuto ma un’articolazione all’interno del Pd, si è determinata nell’Europarlamento ma non a caso: quei parlamentari, poiché devono la propria elezione alle preferenze degli elettori, hanno maggiori margini di autonomia».
È uscita di recente una nuova edizione del tuo “Controvento” in occasione dei i 25 anni dalla scomparsa di Craxi: che anniversario è stato? Siamo ad una svolta nella percezione dell’opinione pubblica più diffusa o c’è ancora molto da fare?
«In questi due mesi sono accadute molte cose: il Presidente della Repubblica ha scritto un messaggio nel quale ha sottolineato la “rilevanza” e “l’autorevolezza” del leader socialista e, mai come stavolta, in tutta Italia si sono svolti ricordi, celebrazioni in affollate sedi socialiste ma anche in tanti luoghi non di partito ma sempre in un clima finalmente attento ai fatti piuttosto che agli opposti pregiudizi. Il Psi ha deciso significativamente di dedicare la tessera al suo ex segretario. Diversi libri ne hanno ricordato l’azione. Se ripensiamo a 30 anni fa, ma anche a 20 o a 10 anni fa, ricordiamo un ostracismo oltre ogni ragionevolezza verso la figura di Craxi. Quella stagione è finita, ma la presa d’atto di una parte di classe dirigente non si è ancora trasmessa in tutti i rami dell’opinione pubblica».
In che senso?
«Nel senso che ad esempio i principali giornali hanno pubblicato il messaggio di Mattarella in piccoli trafiletti: ma questo è il conformismo di chi, prima di esporsi, vuole essere sicuro di non trovarsi in una “falsa posizione”. Lo stesso atteggiamento acritico assunto durante la stagione di Mani pulite: prima occhi chiusi sul malaffare diffuso, poi appena se ne accorge la magistratura, i media si trasformano in ultras».
L’internazionalismo socialista di Craxi, ma anche prima di Craxi e dopo Craxi, quanto sarebbe utile per contribuire all’emancipazione dell’Europa, che rischia di restare schiacciata tra una superpotenza come gli Usa e la Russia, che è una ex superpotenza ma non ha dismesso le ambizioni imperialistiche?
«Sì, hai ragione, c’è un internazionalismo socialista prima di Craxi. Il Psi del “non aderire né sabotare” del 1914 era contro una guerra nazionalista che avrebbe portato tanta morte, milioni di vittime tra contadini e proletari in Italia e in tutta Europa, ma poi quando la guerra sempre in Europa la scatenò il nazifascismo, socialisti e comunisti presero le armi per organizzare la Resistenza. Negli anni Sessanta il Psi riconobbe che era stato giusto cedere una parte di sovranità agli Stati Uniti per vivere in libertà. Craxi, restando nel campo atlantico, si ribellò alle “piraterie” Usa di Sigonella e a quelle anti-Gheddafi. Ma senza il posizionamento del Psi sugli euromissili, forse, non sarebbe caduta l’Urss. Cose grosse. Con un filo rosso: l’ostilità agli opposti imperialismi».
Sì ma perché la migliore lezione socialista potrebbe aiutare la nascita di un’Europa finalmente con un suo protagonismo?
«In effetti manca un nesso chiaro tra il vecchio internazionalismo di sinistra (nella guerra di Spagna, verso gli esuli antifascisti italiani, gli aiuti ai cileni, tante altre solidarietà) e l’urgenza di una nuova Europa. Ma se l’internazionalismo era la fratellanza ideale e concreta tra compagni di diversi Paesi, uniti da ideali comuni, la nuova Europa sta già muovendo i primi passi: puntando alla condivisione di ideali transnazionali, certo non socialisti, ma per i quali i socialisti di tutto il mondo si battono da oltre un secolo: la libertà politica, la libertà dal bisogno, l’eguaglianza delle opportunità. E a livello internazionale, tornando a Craxi, tutti i Paesi europei sembrano pronti al passo decisivo: decidiamo da soli, i “grandi” non decidono più per i “piccoli”».
L’autodeterminazione dei popoli, come essenza della lezione craxiana, può diventare la bandiera di una nuova sinistra?
«Proprio così e non c’è nulla di retorico in questa constatazione. Per un arco di tempo, breve ma bellissimo, il principio dell’autodeterminazione dei popoli fu un ideale condiviso dal giovane Lenin, da Turati e Matteotti, dal presidente americano Wilson che promosse la Società delle Nazioni. Oggi lì siamo tornati: dall’Ucraina che vorrebbe decidere il proprio destino da sola, ai Paesi europei che si preparano a recuperare tutta intera la propria sovranità rispetto agli Stati Uniti d’America».