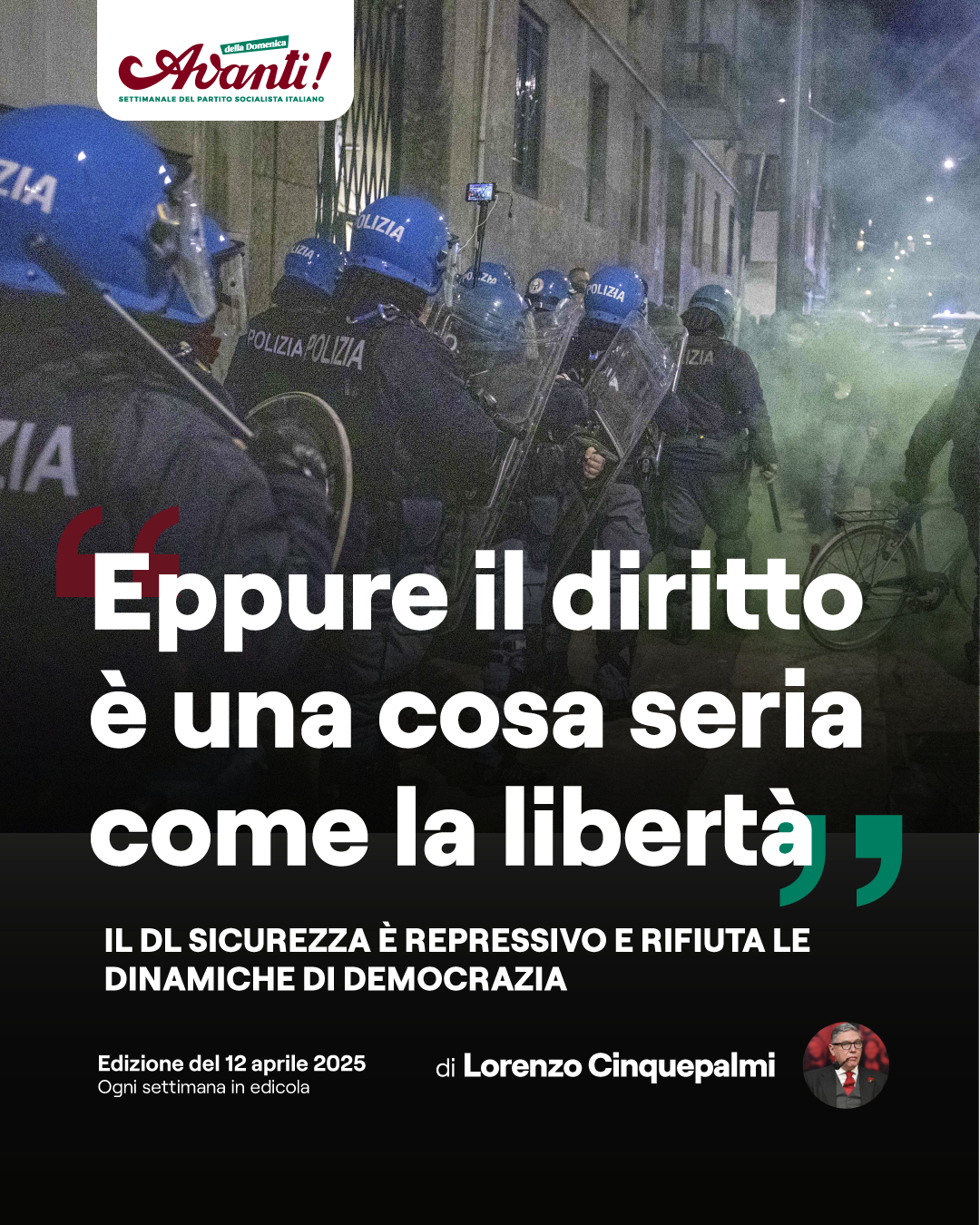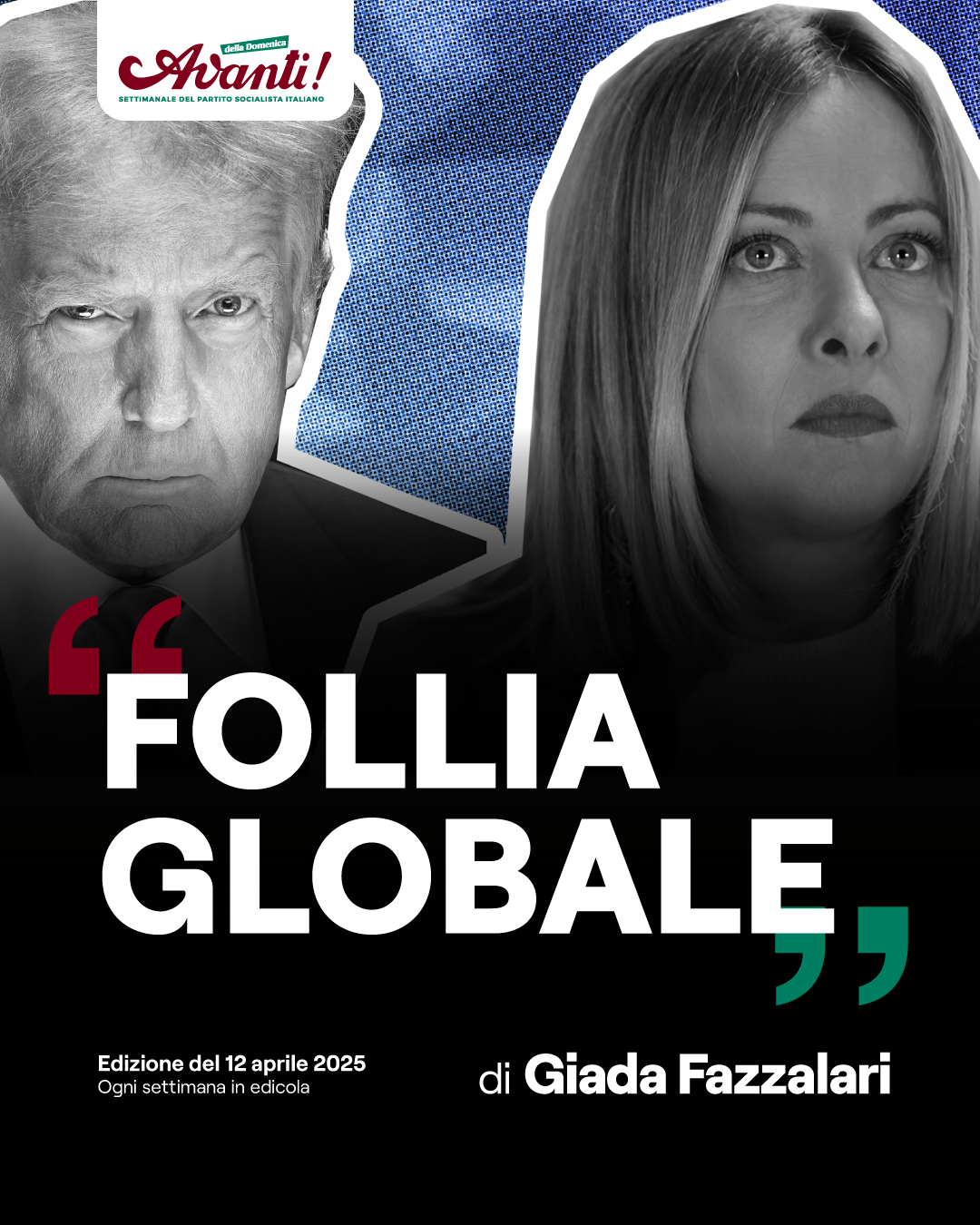di Lorenzo Cinquepalmi
Il consiglio dei ministri a fine 2023 delibera un disegno di legge in materia di sicurezza, che approda alla Camera a inizio 2024. I contenuti sono marcatamente repressivi: una scarica di nuovi reati, dalle caratteristiche tali da prestarsi all’interpretazione manipolativa della polizia giudiziaria, sia nel difficile apprezzamento delle condotte di manifestazioni non violente del dissenso e della protesta, sia nell’evidente soggettivizzazione della rilevanza penale degli atteggiamenti di chi, relazionandosi con operatori delle forze dell’ordine, contesta la legittimità della loro azione. Il disegno di legge contiene anche norme che aggravano le ipotesi di illecito e le sanzioni per condotte poste in essere da cittadini stranieri, norme che favoriscono la repressione delle proteste in carcere, senza ovviamente porsi minimamente il problema se le condizioni di esecuzione delle pene non siano tanto disumane da provocare quelle proteste, norme marchetta ver- so i poliziotti, autorizzati ad acquistare, detenere e portare armi diverse da quelle d’ordinanza. L’iter parlamentare è accidentato e agli accidenti parlamentari si sommano quelli presidenziali, sotto forma di censure preventive di legittimità costituzionale di diversi passaggi del testo di legge. Il testo licenziato alla Camera a settembre 2024, all’arrivo in Senato incontra nuovamente i nodi irrisolti lasciati alle spalle con la forzatura del voto di fiducia, anche perché perfino nella maggioranza qualcuno si rende conto che certe norme proprio non vanno. La prospettiva della terza lettura diventa una certezza. Ed è qui che si consuma lo strappo costituzionale manifesto, dichiarato. Perché se in concreto l’abuso della decretazione d’urgenza è stato prerogativa di governi di ogni estrazione e colore negli ultimi decenni, questa è però la prima volta che cade anche la foglia di fico del rispetto almeno formale dell’articolo 77 della Costituzione, che limita la facoltà del governo di adottare decreti aventi forza di legge in assenza di legge delega del Parlamento, a “casi straordinari di necessità e urgenza”. Chiunque può rendersi conto che la dinamica parlamentare, il dibattito, la dialettica delle parti e dei singoli parlamentari su di un disegno di legge di proposta governativa, rappresenta la normalità e non la straordinarietà della democrazia. Ma per questo governo proprio quella dinamica parlamentare è una fastidiosa e insopportabile perdita di tempo e lo stesso emiciclo per troppi tra ministri e sottosegretari rimane l’aula sorda e grigia di un funesto discorso di un secolo fa. E allora, senza alcun pudore giuridico e costituzionale, il ministro di polizia Piantedosi, in conferenza stampa col desaparecido saltuariamente ritrovato ministro della giustizia Nordio, dichiara al mondo che l’unica ragione straordinaria alla base del ricorso alla decretazione d’urgenza è che il Parlamento ci metteva troppo tempo ad approvare il disegno di legge del governo e che, quindi, Meloni e soci hanno pensato bene di fare il copia-incolla del disegno di legge di così difficile approvazione per trasformarlo in un decreto legge che chi vuole restare parlamentare dovrà approvare e convertire in legge senza tante storie in 60 giorni. Ecco, questo è il punto: “senza tante storie”. Possibile non cogliere la similitudine di atteggia- mento con il governo di cento anni fa, al tempo ancora, seppur per poco, di natura parlamenta- re? Il programma politico dell’allora presidente del consiglio era sintetizzato nell’espressione, attribuitagli dagli storici, “ma a voi c’mandè”. Nel dialetto predappiano suona “io voglio co- mandare”. In fondo, è questo l’approccio della presidente del consiglio Meloni e di troppi suoi scudieri: comandare per comandare, esercitare il potere per esercitare il potere, tenerlo stretto per non cederlo ad altri. L’insofferenza sempre più evidente per quella dinamica squisitamente democratica che gli anglosassoni definiscono “check and balance” dovrebbe preoccupare seriamente tutti coloro che hanno cara la libertà, perché è un attimo arrivare a sentir nuovamente definire le elezioni come “ludi cartacei” da superare. E come è andata a finire l’altra volta ce lo ricordiamo tutti. O almeno si spera.