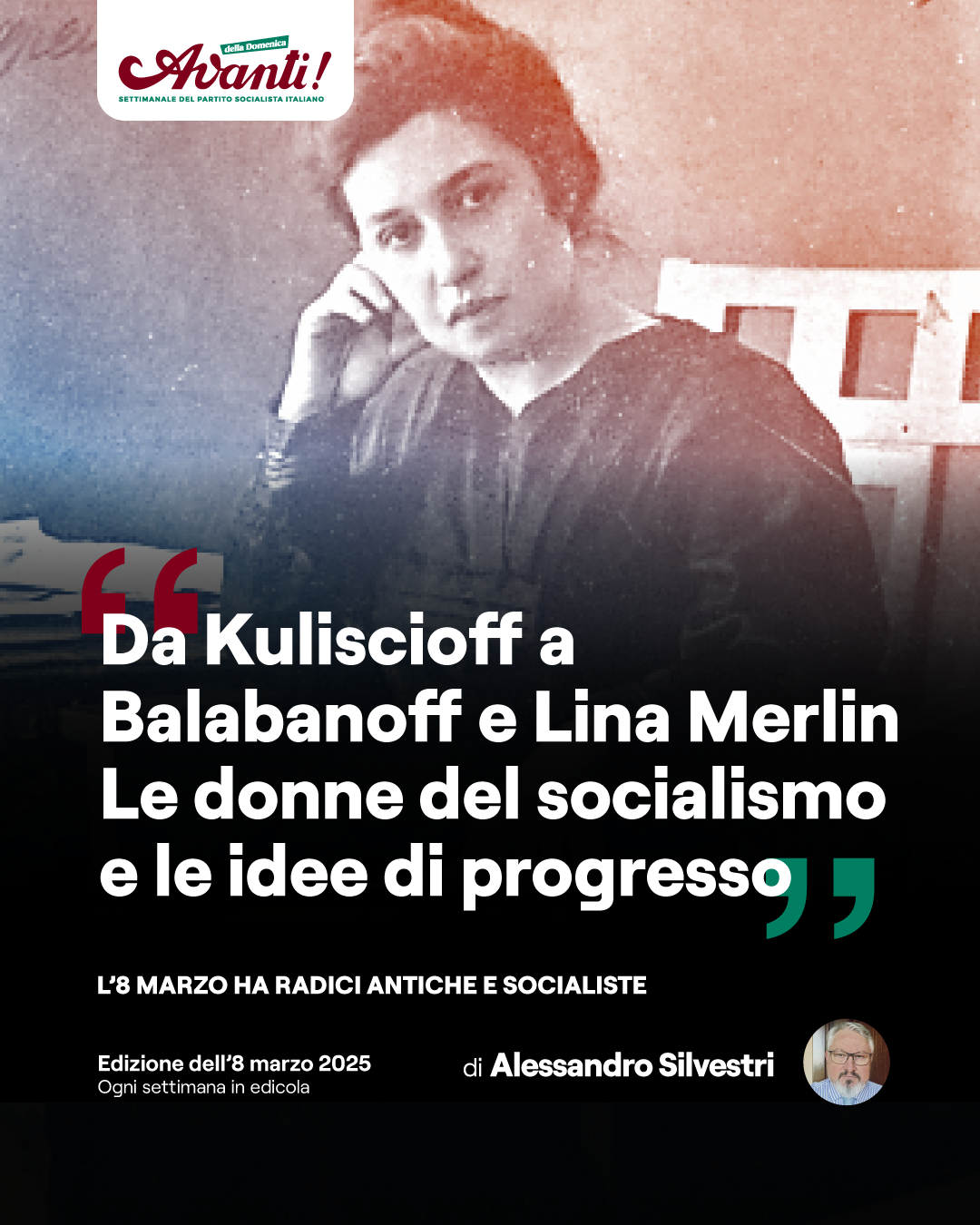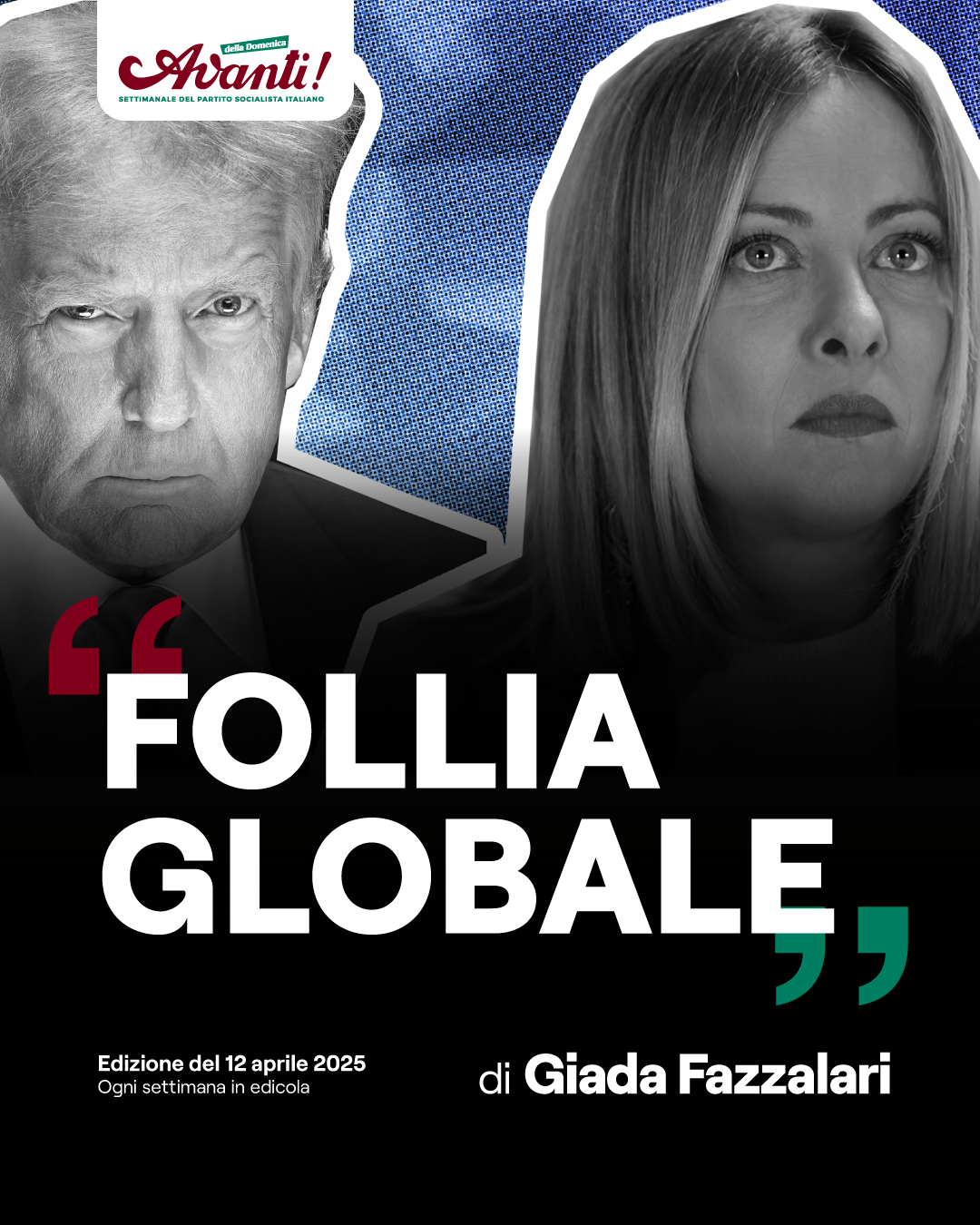di Alessandro Silvestri
L’otto marzo ha radici antiche e socialiste. Occorre percorrere un tragitto lungo e fitto di lotte per l’emancipazione non solo femminile, di abnegazione per le cause di giustizia sociale, di potente fede in un futuro migliore per tutta l’umanità. Bisogna andare idealmente ai lavori della I Conferenza internazionale delle donne socialiste, tenutasi a Stoccarda nel 1907 per rintracciare nei verbali dei lavori, tutte quelle istanze di progresso che saranno l’architrave del femminismo mondiale. Non solo il raggiungimento della parità con l’uomo e nei diritti civili e sociali, ma la fervente convinzione della necessità della partecipazione femminile ai processi di costruzione di una società nuova che superasse le barriere culturali e le frontiere nazionali. Nel 1908 le socialiste americane organizzarono il primo “Woman’s Day” e nel 1910 alla conferenza di Copenhagen, le socialiste di diciassette Paesi proposero l’istituzione di una speciale giornata che rivendicasse i diritti fondamentali delle donne. Sul fronte interno, molte furono le donne che combatterono questa lunga e difficile battaglia di emancipazione e di eresia, piena di nemici e di inciampi, dal cattolicesimo reazionario al fascismo, ad un certo maschilismo prevaricatore, presenza costante nell’autobiografia della Nazione. Una breve carrellata delle protagoniste più note, anche se migliaia furono le anonime attiviste impegnate in questa lotta di civiltà: operaie, braccianti, sarte, insegnanti, infermiere e “serve”, alle quali va tutto il nostro affetto e riconoscenza. “A Milano non c’è che un uomo, che viceversa è una donna, la Kulisciova”. Con questa celebre definizione, Antonio Labriola scriveva una lettera a Friedrich Engels nel luglio 1893. E proprio nel centenario della sua morte, non potevamo fare a meno di ricordare colei che aveva assunto lo pseudonimo di Anja Kulisceva (italianizzato Anna Kuliscioff) per sfuggire alla condanna dei tribunali zaristi per sedizione, dopo aver seguito e affiancato le attività politiche rivoluzionarie di Michail Bakunin e del primo marito, Pëtr Makarevič. La dottora dei poveri, come veniva chiamata a Milano, la città che l’accolse e che vide la sua febbrile attività dipanarsi tra medicina e politica. Rifiutata dall’ospedale Maggiore perché donna, prestò gratuitamente servizio presso l’Ospedale dei poveri, creato da Alessandrina Ravizza. I suoi studi sulle infezioni puerperali salveranno la vita a tantissime donne condannate in precedenza alle frequenti “morti da parto”. La sua attività politica fu non meno importante, e al suo sodalizio con Filippo Turati si debbono molte delle intuizioni che anticiparono anche di decenni, lo sviluppo del socialismo democratico italiano ed europeo, tanto dalle pagine di “Critica Sociale” che nelle attività parlamentari. Un’altra milanese, Anna Maria Mozzoni, aveva anticipato le istanze del femminismo con la pubblicazione nel 1864 di “La donna e i suoi rapporti sociali”. Presente nel 1878 a Parigi al Congresso internazionale per i diritti delle donne, in rappresentanza dell’Italia; aderì al partito socialista e fu attiva praticamente fino ai suoi ultimi giorni assieme, tra le altre, a Linda Malnati e Carlotta Clerici. Un’altra straordinaria ucraina, divenuta autorevole attrice della politica italiana, della quale ricorre anche quest’anno l’anniversario (il 60°), è stata senza alcun dubbio Angelica Balabanoff. Figura autorevole già dell’epopea bolscevica, vicinissima a Lenin, segretaria della III Internazionale e della Conferenza di Zimmerwald, fu ambasciatrice in Svezia, prima di distaccarsi per sempre, dopo i fatti di Kronstadt, da quella che a suo avviso (e grandissimo dolore), si stava trasformando in una dittatura sanguinaria. Fu a Roma per la prima volta nel 1900 e subito volle iscriversi al Partito Socialista Italiano, del quale condividerà dopo il distacco definitivo dall’Unione Sovietica, gioie e dolori fino alla fine. Nel 1904 a Lugano assieme a Maria Giudice (altra figura di spicco del femminismo e del socialismo) fondò il giornale “Su Compagne”. Nel 1912 affiancò Mussolini nella direzione dell’Avanti! e anche durante il fascismo continuò a dirigere in esilio, il quotidiano divenuto clandestino. Ostile al frontismo, dopo la guerra aderì al PSLI di Saragat. Ma il nostro album di famiglia è pieno di donne che hanno anteposto a tutto, la lotta per i diritti degli ultimi e delle donne, ultime tra gli ultimi. Come le sindacaliste romagnole Argentina Altobelli e Maria Goia, sulle quali sarebbe necessaria una biografia di molti tomi. Alla Costituente si distinsero Bianca Bianchi, insegnante toscana, eletta segretaria della Presidenza dell’Assemblea, autrice di molti interventi dedicati alla scuola e all’importanza della presenza femminile nelle istituzioni pubbliche; così come la collega veneta Lina Merlin, autrice dei passaggi fondamentali dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini…sono uguali davanti alla legge” […] “senza distinzioni di sesso”. Nel 1958 sarà promotrice della legge 75 che abolì le “case chiuse” e la precedente regolamentazione pubblica sulla prostituzione. Oggi le donne sono esattamente un terzo dei due rami parlamentari (200 su 600) in flessione rispetto alla legislatura precedente, dove si era giunti al 35% nel 2018. Segno evidente che tutte le conquiste, le civili come le democratiche, hanno bisogno costantemente di nuova linfa per crescere e radicarsi.